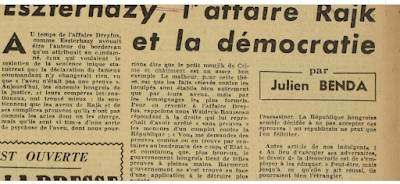|
| Padova |
RINNOVARE IL
PALAZZO DELLA RAGIONE
1. La fuga dalla ragione
In molte grandi città d’Italia c’è
un Palazzo della ragione, un edificio pubblico dedicato alla vita
comunitaria e all’amministrazione della giustizia. Che una città decida di
porre questo sacro nome sulla facciata del suo principale edificio civico è
sempre stato una fonte di stupore ammirativa per quei filosofi che stimano la
Ragione. Ma ora siamo lontani dall’epoca medievale in cui la maggior parte di
questi palazzi fu edificata. Dopo aver dato il suo nome all’età
dell’illuminismo, la Ragione è caduta in discredito. Possiamo noi restaurare il
suo perduto splendore?
Ciò sembra senza speranza. Il ventesimo
secolo è stata l’epoca del declino della ragione. La filosofia in Europa è
stata dominata fin dagli anni venti da un filosofo tedesco che ha proclamato
che l’essenza della ragione è Gestell, e che non ha trovato alcuna
contraddizione nell’essere al contempo un filosofo e un membro del partito
Nazista. Dopo la seconda guerra mondiale l’esistenzialismo ha affermato che la
libertà non è altro che una scelta irrazionale che crea i propri valori.
Horkheimer e Adorno hanno proclamato l’ “eclisse della ragione” e hanno
lanciato il tema della responsabilità del razionalismo nell’ascesa del
totalitarismo. Prima degli anni quaranta, la difesa degli ideali della ragione
era prerogativa dei pensatori di sinistra o liberali – come Julien Benda, Benedetto
Croce, Bertrand Russell, José Ortega y Gasset o Thomas Mann – mentre
l’irrazionalismo era il marchio della destra politica. Dopo la seconda guerra
si è verificato uno spettacolare capovolgimento: l’attacco della ragione è
divenuto il motto della sinistra, e quelli che l’hanno difesa sono stati
sospettati di essere liberali conservatori. Niente mostra meglio questo fatto
del Nietzschianesimo, che è stato prima considerato come elitista e
antidemocratico, ma più tardi è divenuto la bibbia del pensiero di sinistra
nelle mani dei pensatori radicali degli anni settanta come Michel Foucault, Gilles
Deleuze e Jacques Derrida. L’ Esistenzialismo, l’ Heideggerianismo, il
post-modernismo, il post-strutturalismo, il neo-pragmatismo e il pensiero
debole, hanno proclamato la vacuità
dei valori della ragione e denunciato la cosiddetta tirannia del Logos.
Sembra che le guerre della scienza siano state vinte da quei sociologi
della conoscenza che hanno contribuito al trionfo del relativismo e sostenuto
che i valori “Mertoniani” della scienza (comunalismo, universalismo,
disinteresse e scetticismo organizzato) siano mere finzioni che mascherano
interessi industriali e il desiderio del potere. D’altra parte l’anti-ragione
non è un tema meramente filosofico. Essa è un leitmotiv del Zeitgeist.
dai surrealisti ai post-modernisti, i freddi ideali della ragione sono stati
considerati come i nemici della creazione artistica.
Ci sono almeno tre conseguenze maggiormente evidenti di questa fuga
dalla ragione in filosofia e nella cultura in generale. La prima è stata ben
descritta da C.P. Snow in Le due Culture:
dagli anni trenta in poi il pubblico intellettuale ha smesso di essere un
difensore della verità e dell’oggettività, e il divario tra letteratura
scientifica e letteraria è aumentato drammaticamente. Al tempo dell’affare
Dreyfus in Francia gli intellettuali potevano parlare in nome della scienza e
di valori universali contro gli uomini di lettere che difendevano valori
nazionali. Dagli anni trenta in poi, matematici e scienziati sono stati esclusi
dalla sfera pubblica, e il nome di “intellettuale” è stato riservato unicamente
a persone nella sfera letteraria. La filosofia, spesso associata alla scienza
almeno fino al positivismo logico degli anni trenta, dopo la seconda guerra
mondiale è stata invece essenzialmente associata alle scienze umane. L’idea che
un fisico o un matematico possano parlare di valori pubblici è divenuta sempre
più aliena alla nostra cultura[1].
La seconda conseguenza, che è un corollario della prima, è che la
filosofia ha smesso di aspirare ad essere una disciplina teoretica, ed ha
cominciato ad essere confinata a questioni etiche e politiche. Si è sempre
supposto che i filosofi fossero amanti della saggezza, ma l’idea che la
saggezza potesse provenire dall’acquisizione di conoscenza teoretica o dal
possesso di certe verità riguardanti il mondo è divenuta sempre più sospetta.
Si è letta la stessa filosofia antica come essenzialmente promuovente una saggezza
pratica, e lo storico Pierre Hadot ha convinto molti che il fine
dell’antica filosofia greca non fosse mai
stato teoretico. I Neo-Kantiani da Fichte a Habermas hanno sostenuto che se ci
può essere ragione in filosofia essa deve essere pratica e confinata al dominio
dell’etica. La stessa idea che la filosofia possa produrre qualche tipo di
conoscenza, o anche solo contribuire al progresso conoscitivo, è divenuta
completamente obsoleta.
La terza conseguenza, forse la più visibile, è che la filosofia è
divenuta un soggetto popolare. Nonostante alcuni filosofi come Bergson o
Russell abbiano conquistato gloria letteraria durante la prima metà del
ventesimo secolo, la filosofia era ancora rimasta prevalentemente una
disciplina academica. Sartre in Francia aprì la via a carriere filosofiche
condotte completamente al di fuori dell’università. I pensatori radicali degli
anni settanta – Foucault, Deleuze, Derrida, presto seguiti da Rorty negli Stati
Uniti, Negri , Vattimo e Agamben in
Italia, Sloterdijk e Zizeck in Germania–
hanno tutti interrotto i loro iniziali legami con la filosofia accademica.
Molti dei loro successori sono diventati giornalisti o autori di best-sellers.
Oggi la filosofia è ovunque nei media, nei programmi radiofonici e televisivi,
su internet e nelle riviste. Essa non propone più un messaggio di rivolta
contro poteri politici e di cambiamento del mondo. Sovente i filosofi pubblici
contemporanei non aspirano a niente di più che produrre un tipo di sociologia
del presente unita ad una versione soft
dell’etica delle virtù. Il filosofo come consulente morale e come terapista è
la controparte del filosofo come giornalista. Molti filosofi hanno adottato i
valori del giornalismo: scrivere veloce, solo su questioni contemporanee,
prendere seriamente un opinione solo se è considerata molto importante e
diffusa, abbandonarla se la gente si stanca di essa, non perché ingiustificata,
e evitare ogni apparenza di apprendimento e erudizione e in generale alcunché
possa far supporre una qualche forma di studio da parte del lettore.
Anche se ai suoi tempi non poteva contemplare lo tsunami della cultura
pop sulla filosofia, Franz Brentano ha descritto accuratamente quattro
principali fasi della filosofia: creativa e teoretica, orientata alla
produzione di conoscenza scientifica con Platone e Aristotele, poi etica,
orientata a interessi pratici e alla ricerca della felicità con la filosofia
Ellenistica, poi scettica con Hume e l’Aufklärung, e
infine mistico-dogmatica con Kant e i suoi successori. Forse Brentano avrebbe
descritto la nostra presente fase del dominio dell’opinione sulla filosofia
come un ritorno al relativismo Pitagorico.
Nel contesto odierno, il tentativo di
rianimare la ragione e ritornare, come suggerito da Brentano, alla prima fase
scientifica, sembra essere vano come il tentativo di riproporre la teologia
Tridentina. Julien Benda, uno dei pochissimi intellettuali ad aver lucidamente
contemplato al suo tempo il naufragio degli ideali della ragione e denunciato
il “tradimento dei chierici” che sacrificarono il culto delle pure idee
all’impegno politico, difese “la rigidità della ragione”[2].
Ma, ci si potrebbe chiedere, che senso avrebbe tornare indietro ad un ideale
che sembra essere definitivamente tramontato ? Certo se ci troviamo nella morsa
di un senso Hegeliano della necessità storica nel dominio delle idee, ciò non
ha senso. Ma il razionalismo non riconosce la necessità all’interno della
storia. La ragione appartiene al dominio degli ideali, che sono indipendenti
dalle contingenze della storia e che si possono sempre opporre ad essa. In
questo senso il razionalismo non è un ideale di ieri, ma per ogni tempo.
2. Può la filosofia analitica incarnare i valori della ragione?
Alcune delle opposizioni emerse nella
filosofia contemporanea durante l’ultimo secolo si potrebbero descrivere come
il prodotto di un altro fenomeno delle “due culture”: la distinzione
“analitico/ continentale” in filosofia. È stato detto che il famoso congresso
di Davos nel 1929 sia stata la pietra miliare della separazione dei due mondi
filosofici. Cassirer, il principale rappresentante del Kantismo razionalista,
perse la battaglia contro la gloria ascendente di Heidegger, mentre Carnap, il
terzo partito, percorse la sua via contro gli altri due[3]. Per
molti versi la filosofia analitica ha ricevuto l’eredità della filosofia
scientifica, mentre la filosofia
continentale ha ricevuto l’eredità dell’antirazionalismo post-Heideggeriano.
Positivismo contro ermeneutica, argomentazione contro stile letterario, logica
contro intuizione, preoccupazioni teoretiche contro preoccupazione per “la
vita”, cenacoli accademici contro cultura pubblica, tutto sembra costitutivo
della separazione. La filosofia analitica durante il ventesimo secolo ha tenuto
viva la fiamma della ragione?
Certo, l’ha fatto. Ma non è chiaro che
essa abbia tenuto viva la fiamma in tutte le sue incarnazioni. La filosofia
analitica è stata, per la maggior parte della sua storia durante il ventesimo
secolo, la rappresentativa dei metodi tradizionali e della ragione: i filosofi
analitici hanno coltivato la scrittura chiara e argomentata, l’uso della logica
e dei metodi formali, e in generale sostenuto gli ideali dell’illuminismo e
della filosofia scientifica. Ma se si considerano le (specifiche) dottrine, è
meno ovvio che la filosofia analitica possa esser descritta come
razionalistica. Molta della prima filosofia analitica durante il secolo
precedente è stata critica delle tesi del razionalismo classico. Molta
dell’originaria filosofia analitica (Russell, Moore) è una rivolta contro i
razionalismi di Descartes (Cartesio), Leibniz, Spinoza, Kant e Hegel. Molta
della filosofia analitica di metà secolo, con i positivisti logici, è legata ad
una forma di empirismo che rifiuta ogni conoscenza a priori che non è puramente semantica. Più tardi W.V.O. Quine ha
rifiutato la divisione tra verità vera in virtù del significato e verità in
virtù di com’è il mondo. Se
interpretiamo il razionalismo come la prospettiva secondo la quale si può
conoscere la realtà, molta della filosofia analitica è scettica riguardo alla
possibilità di tale conoscenza. Molti autori all’interno della filosofia
analitica, inclusi Carnap, Wittgenstein e Strawson, sono post-Kantiani, e
dubitano che la ragione possa raggiungere
la natura delle cose. La tarda filosofia di Wittgenstein è meglio
interpretata come una forma di anti-realismo che evita questioni metafisiche, e
molto del positivismo logico è neutralista e deflazionista rispetto a problemi
come la natura della verità, gli universali e l’ontologia in generale.
Nonostante la recente rinascita dell’ontologia a partire da Saul Kripke e David
Lewis, molti filosofi analitici simpatizzano con l’idea di Wittgenstein che i
problemi e le tesi filosofiche si basino su illusioni della comprensione. Molti
epistemologi analitici hanno rinunciato ad ogni tentativo di
teorizzare/produrre/fornire una fondazione della conoscenza e rispondere alla
sfida dello scettico e sostengono prospettive “contestualiste” della conoscenza
secondo le quali la conoscenza viene e va dipendentemente dalle varie
circostanze della sua attribuzione o valutazione. Alcuni di questi filosofi
hanno persino riconsiderato prospettive “relativiste” secondo le quali ci può essere
“disaccordo senza errore” in molte aree del discorso. Inoltre gran parte della
filosofia analitica contemporanea è sospettosa delle prospettive razionaliste
classiche. In filosofia della scienza, l’”empirismo costruttivista” di Bas Van
Fraassen afferma che non possiamo mai dire che le nostre teorie scientifiche
sono vere ma possiamo solo accettarle come empiricamente adeguate. In etica,
molti filosofi seguono l’ “astinenza epistemica” di Rawls riguardo alla verità
in etica e accettano il motto di Putnam di un’ “etica senza ontologia” o l’
“etica senza principi” di Rorty. Attualmente molta della filosofia
“post-analitica” contemporanea si è occupata di temi relativisti e scettici che
rimandano al pensiero post-modernista. Quando Rorty difende l’ “edificazione”
contro l’argomentazione, e quando Cavell ci ingiunge di rinunciare ad ogni
tentativo fondazionale o esplicativo e di coltivare “l’ordinario”, non siamo
molto lontani da Heidegger. Il relativismo e lo scetticismo non sono limitati
ai confini della filosofia post-analitica. Il forte orientamento del
naturalismo nella filosofia analitica contemporanea che è un erede
dell’empirismo Quineano e dello sviluppo delle neuroscienze cognitive è anche
molto sospettoso di idee fondazionali e della conoscenza a priori.
Alcune delle sue tendenze più radicali invocano una dissoluzione della
filosofia nella scienza empirica. Gli auto-proclamatisi “filosofi sperimentali”
ci dicono che la maggior parte dei nostri concetti e intuizioni filosofiche
sono vincolati da una cultura e non hanno validità universale, contrariamente a
ciò che la tradizione razionalista in filosofia ha sempre presupposto. Non è
quindi sorprendente che alcuni di essi trovino attrattive alcune idee
Nietzscheane.
La filosofia analitica è ora una villa
troppo ampia con troppe stanze per essere ridotta ad una sola corrente . Ma è
necessario ammettere che molte prospettive che sono state definite “analitiche”
non sono particolarmente favorevoli al razionalismo. Quindi, alla domanda posta
nel titolo di questa sezione io risponderei solo con un qualificato “si”.
3.
Il regno della ragione
Ma quali sono esattamente i criteri del razionalismo? “Ragione” è una
parola particolarmente ambigua. Il razionalismo in generale e in filosofia in
particolare comporta vincoli sia sostantivi che critici, che enuncerò qui in
qualche modo dogmaticamente.
Prima distinguiamo tra vincoli sostantivi o dottrinali del razionalismo
da un lato e vincoli critici o metodologici dall’altro. Ci sono quattro vincoli
sostantivi fondamentali del razionalismo: (i) metafisici: possiamo avere
conoscenza di una realtà oggettiva indipendente dalla mente; (ii) epistemologici:
almeno una parte della nostra conoscenza del mondo è a priori, nel senso
che si basa su principi che sono indipendenti dall’esperienza; (iii) unità: ci sono stabili leggi della ragione
e del pensiero, che l’esperienza non può cambiare ; (iv) normatività: ci sono norme e valori
razionali, basati sulle leggi della ragione, che sono a priori e che devono essere
rispettate.
Ci si potrebbe domandare se questi vincoli di fatto definiscano il
razionalismo. Ora, alcuni filosofi, come Leibniz e Kant, sono razionalisti nel
senso epistemologico (ii) ma non sono realisti metafisici nel senso (i); essi
sono idealisti. Per converso si può essere realisti metafisici senza essere
epistemologicamente razionalisti (un gran numero di naturalisti e empiristi
sono realisti metafisici). In che misura, tuttavia, si può essere razionalisti
epistemologici negando al tempo stesso il realismo metafisico? L’idealismo
“assoluto” di Hegel, e alcune versioni di pragmatismo, considerano il mondo
come razionale. Questi sistemi contano come razionalisti? In un senso si, dal
momento che essi considerano la verità riducibile alla giustificazione, e il
mondo come identico alla mente.
Tuttavia, ci si potrebbe domandare se un autentico razionalista possa
accettare che la verità non può oltrepassare
la giustificazione. L’affermazione Hegeliana che la ragione può
conoscere ogni cosa è effettivamente opposta al razionalismo genuino,
che accetta che vi siano verità inconoscibili. Direi che lo stesso vale per
neo-Hegeliani dei giorni nostri come Robert Brandom, o neo-Kantiani come Jürgen
Habermas o Hilary Putnam per i quali la verità è giustificazione ideale
razionale. Lasciatemi definire queste forme di razionalismo immodeste.
Il razionalismo che si accompagna agli ideali della ricerca scientifica,
tuttavia, è del tipo modesto: esso non pretende che la ragione non abbia
limiti, e considera la conoscenza umana come limitata. In altre parole esso
accetta una forma di realismo per il quale la verità può eccedere
l’accettabilità razionale. Per neo-Kantiani la verità non puo estendersi oltre
la giustificazione. In altre parole, il rationalismo implica il concetto
realisto di verità[4].
Pertanto il realismo nel senso di (i) forma il nucleo dei vincoli del
razionalismo. Il realismo puoi essere
limitato. Per essenpio e possibile d’essere piu o meno realisto dipende
all tipo di discorso: il realismo matematico non implica necesarmente il realismo morale. Ma senza l’idea d’una
conoscenza oggetiva e d’una realta independente e non mentale il razionalismo
non é veramente un razionalismo. Ciò non significa che tutti i razionalisti
debbano seguire la stessa agenda. Un razionalista, per esempio, non deve
necessariamente essere un realista riguardo agli universali o alle entità
astratte. Egli può essere un nominalista riguardo agli universali. Inoltre,
nonostante il razionalismo comporti l’accettazione di una distinzione tra
conoscenza a priori e a posteriori, non tutti i razionalisti
devono tracciare la distinzione allo stesso modo.
Non è così chiaro che un razionalista debba accettare i quattro
precedenti vincoli. Un autentico razionalismo, un razionalismo sanguigno o
vigoroso, per cosi dire, comunque, deve accettarli tutti. Primo, gli ideali della ragione sarebbero vuoti se l’esercizio
della ragione non potesse aiutarci a raggiungere un mondo oggettivo nel senso
richiesto dal realismo. Secundo essi
non avrebbero senso se non si accettasse che almeno certi principi sono indipendenti dall’esperienza e non
rivedibili. Tertio , questi ideali
sarebbero privi di forza se le norme della ragione non possedessero un grado
significativo di unità e stabilità. Quarto
ed essi sarebbero impotenti se non avessero forza normativa e capacità di
guidarci nelle nostre ricerche. D’altra parte gli scetticismi e relativismi di
tutti i tipi rifiutano i quattro vincoli e considerano il mondo come
inconoscibile. L’empirismo e il naturalismo riduttivo rifiutano il secondo, il
terzo e il quarto vincolo. Moltissimi pragmatisti – eccetto Peirce, che era un
realista pragmatista – rifiutano i quattro vincoli.
Il razionalismo comporta anche principi
critici e metodologici ,
maximio regole per la direzionedell’ intelligenza, che seguono naturalmente da
quelli sostantivi. Un razionalista sostiene che le norme della ragione sono
costitutive del nostro pensiero, ma ciò non significa che non dobbiamo fare
nulla per mettere questi ideali in pratica. Valutare la ragione è rispettare i
suoi principi. Ed essere guidati da essi. Rispetto per le leggi della logica
implica credere nell’unità della logica e nella forza delle sue leggi. Il
principio di contraddizione è scritto sulla facciata del Tempio della Ragione.
Alcuni logici, tuttavia, rifiutano la logica classica. Sono essi espulsi dal
Sacro Tempio della Ragione? Non necessariamente, dal momento che tutti i logici
accettano che ci siano principi minimali di inferenza. Comunque affermerei che
un autentico razionalismo non è compatibile con una forma estrema di pluralismo
logico, secondo il quale ci sarebbero molti sistemi logici alternativi. Il
principio di tolleranza di Carnap, che dice che in logica non ci sono morali, e
che ciascuno è libero di scegliere un sistema secondo i propri bisogni, è più
consono ad un tipo di pragmatismo che al razionalismo. Il razionalismo può
accettare l’idea che non c’è un unico insieme di principi logici universali, ma
non può accettare che la logica sia solo uno strumento o un organon.
Essa deve essere un canone. Certamente la riverenza per la logica non è
esclusiva del razionalismo, ma il disprezzo per la logica e coltura del
ragionamento impostore e fallace è chiaramente il più sicuro senso di
irrazionalismo e misologia.
Una delle più importanti interpretazioni del quarto vincolo del
razionalismo – l’esistenza di valori razionali – ha una controparte critica,
che è che ci sono norme della ragione. Le norme più astratte e generali
sono quelle della conoscenza e della ricerca, in particolare la norma della
verità – si deve ricercare la verità, e evitare l’errore – e la norma
dell’evidenza – si deve credere solo sulla base di evidenza sufficiente. Queste
formano ciò che è spesso chiamata, nei termini usati da William Clifford, l’
“etica della credenza”. Esse sono le norme epistemiche che i pensatori
dell’illuminismo fin da Locke e Voltaire hanno sempre difeso in nome della
Ragione, specialmente contro forme di entusiasmo religioso e non. Esse sono il
nucleo dell l‘Illuminismo insieme a quelle che Kant ha chiamato “le massime del
senso comune” – pensare da sé, pensare al posto dell’altra persona, sempre
pensare in modo coerente con se stessi. La massima di Clifford, benché sia un
affermazione metodologica, è l’espressione di ciò che si avvicina ad essere un
quinto principio sostantivo del razionalismo: (v) evidenzialismo: solo
l’evidenza può giustificare una credenza. La norma evidenzialista si
contrappone alla dottrina pragmatista, difesa da William James, secondo cui la
credenza è una questione della volontà – che la credenza, il giudizio e la
ragione in generale possono essere giustificate dalla sola azione. La dottrina
volontarista riguardo alla credenza si rifà a Cartesio e alla sua concezione
del giudizio come sotto il controllo della volontà. Cartesio ha sostenuto che Dio crea le eterne verità
della logica e della matematica dalla propria libera volontà. Di fatto Cartesio
è ritenuto un razionalista kat’exochèn
. Ma l’idea che Dio possa rendere vero, con la sua volontà, che due più due non
fa quattro è davvero razionalista? Leibniz ha sostenuto contro la tesi di
Cartesio , giustamente a mio avviso, che essa implica effettivamente
l’introduzione di un elemento irrazionale all’interno della ragione. Le verità
della Ragione non dipendono da alcuna volontà. In questo senso l’anti-volontarismo
è un principio fondamentale del razionalismo: pensiero, ragione e verità
non sono di nostra fattura.[5]
Certamente
il razionalismo non possiede il copyright di queste norme epistemiche – gli
empiristi possono accettarle entrambe e i pragmatisti possono almeno accettare
la norma della verità sebbene essi
rifiutino la norma dell’evidenza – ma i razionalisti si trovano in una
posizione migliore di ogni altro filosofo per difendere il loro status
normativo. Un filosofo che, come molti pragmatisti, dicesse che le regole della
ricerca non sono immuni da revisione o sono mere massime strumentali, di fatto
negherebbe la loro forza normativa. Peirce è un’eccezione. Egli ha sostenuto
che “la prima regola della ragione” è “mai ostacolare la via della ricerca”, e
differisce da moltissimi altri pragmatisti nel considerare tali principi come a
priori e non rivedibili. Egli anche rifiuta la dottrina della volontà di
credere di William James.
L’esatta natura delle norme della ragione e la misura in cui i principi
della logica sono normativi è oggetto di disputa tra i razionalisti e i loro
avversari, ma anche all’interno dell’ambito razionalista. Dovremmo ragionare
secondo i principi della logica classica o secondo le leggi della probabilità?
La ragione si esaurisce nel suo senso logico? C’è un dibattito, in particolare
nella teoria dell’azione e della decisione, se i condizioni della razionalità
siano sostantivi – riguardino le azioni in se stesse – o meramente “procedurali”
– riguardino meramente la procedura per raggiungere una decisione. La forma
precisa che i principi della ragione, sia sostantivi che critici, dovrebbero
assumere è ancora un problema irrisolto.
Ho formulato i vincoli del razionalismo nei termini di condizioni
riguardanti la ragione teoretica, ma si può essere razionalisti anche nel
dominio pratico. Tradizionalmente il razionalismo morale è la prospettiva
secondo la quale requisiti e norme etiche non seguono da sentimenti e passioni,
ma dalla sola ragione. Ancora una volta, non affermo che un razionalista
genuino debba essere un razionalista in tutti gli ambiti, incluso quello etico.
Ma almeno un vincolo mi sembra che sia fondamentale rispetto a tutti gli altri
tipi di razionalismo: l’idea che la ragione teoretica venga prima, e che è
meglio soddisfatta in associazione con il pensiero scientifico piuttosto che in
opposizione ad esso. Un razionalista che si limitasse alla sfera morale e
pratica, come Fichte o Habermas, sarebbe solo per metà nel regno della ragione.
4.
Come rinnovare il Palazzo della ragione
Ho indicato la forma che, a mio avviso, il razionalismo possiede. Ma la ragione é una bella addormentata nel bosco della filosofia nell suo castello,
forse per piu di cento anni. Dove il Principe chi porrei svegliare la
Principessa Ragione? La storia e difficile a credere, perché le Principesse
e il Principi sono per lo piu irrationalisti. Porrei la Principessa
della Ragione svegliare e dire all Principe:
"Siete voi, o mio Principe?", ella gli disse. "Vi siete
fatto molto aspettare!". Ma dove potremmo trovare quello Principe?
Vorrei ora indicare quale forma esso dovrebbe assumere. Il rinnovamento
di una posizione classica in filosofia non significa l’adozione delle stesse
dottrine del passato. Proprio come Leibniz quando tentò di rinnovare le forme
sostanziali della filosofia scolastica nel XVII (diciassettesimo) secolo non
riformulò le dottrine aristoteliche in quanto tali ma cercò di adattarle alla
fisica dei suoi tempi, il razionalismo dovrà reinventare le proprie categorie e
le proprie tesi fondamentali.
Un modo in cui esso dovrà essere reinventato riguarda la sua relazione
con il naturalismo. Il razionalismo classico si è basato su una concezione
della ragione come una facoltà naturale che distingue l’uomo da altre creature.
Gran parte della difesa del razionalismo epistemologico contro l’empirismo si
basa sulla dottrina delle idee innate. Nonostante Chomsky e Fodor abbiano
tentato di riproporre questa dottrina nel contesto della scienza cognitiva
contemporanea, il razionalismo non è necessariamente legato ad essa. Né è
necessariamente opposto al naturalismo. Il fatto che gli esseri umani siano
animali evoluti non costituisce un limite al fatto che parte della loro
conoscenza sia non empirica. Pensare altrimenti sarebbe commettere una fallacia
genetica: confondere le origini delle nostre idee con le condizioni della loro
validità. Allo stesso modo benché molti razionalisti classici abbiano sostenuto
che la conoscenza a priori si basi su una facoltà dell’intuizione o
introspezione, il razionalismo non deve necessariamente fare appello ad una
tale misteriosa facoltà. Il razionalismo contemporaneo è perfettamente libero
di sostenere che la conoscenza a priori si basa sulla natura dei nostri concetti più fondamentali e sulle norme
che sono da essi implicate. Quindi, mentre i concetti percettivi sono associati
a certi tipi di garanzie che ci assicurano quando siamo autorizzati alla
conoscenza percettiva, i concetti logici sono associati a certi tipi di
garanzie inferenziali.[6]
Il leitmotiv del razionalista è che la filosofia è il dominio di ragioni
e di norme. Il razionalismo non asserisce solamente la loro realtà contro
scettici e relativisti, ma anche la loro autonomia da fatti naturali contro i
naturalisti riduzionisti. Larga parte dell’agenda per un futuro lavoro
filosofico in questo ambito consiste nel porsi domande come le seguenti: gli
enunciati normativi sono fattuali? Se si quale tipo di fatti? Sono le norme
riducibili ai valori? A ideali di razionalità? O sono esse riducibili a ragioni,
secondo ciò che è a volte chiamato il “buck passing” account dei valori[7]? Come possiamo conoscerli e
come essi possono regolare i nostri pensieri e le nostre azioni? C’è una
differenza fondamentale tra norme epistemiche e ragioni per pensare da un lato
e norme pratiche e ragioni per agire dall’altro? O la loro struttura è
essenzialmente la stessa? Molte di queste questioni, che sono di pertinenza
della meta-etica e della meta-epistemologia, sono già centrali in lavori
contemporanei[8]. In epistemologia c’è un
contrasto tra prospettive “internaliste”, secondo le quali per sapere qualcosa
si deve sapere di sapere e conoscere le proprie ragioni, e prospettive
“esternaliste”, secondo le quali la conoscenza non richiede ragioni. In
psicologia morale c’è un’opposizione tra teorie che sostengono che le nostre
ragioni per agire devono motivarci, e teorie esternaliste che negano tale
condizione. Gran parte del progetto razionalista consisterà in un’analisi della
struttura dell’ambito normativo delle ragioni in entrambi i domini.
Questo tipo di progetto si potrebbe definire critico, dal momento che
esso consiste nel cercare di comprendere i limiti della cognizione e
dell’azione nei suoi termini più generali. Esso ha un tono Kantiano, ma non è
necessariamente legato ad alcun progetto di una filosofia trascendentale nel
senso Kantiano. Molti tentativi sono stati fatti, fin dalla fine del
diciannovesimo secolo, per riportare in vita l’approccio critico di Kant. Gran
parte di questi tentativi ha fallito perché essi si sono basati su una
concezione troppo ristretta dell’a priori o perché non sono stati capaci
di tenere in considerazione la natura della conoscenza scientifica
contemporanea. Ma vi sono altri modi di comprendere il progetto critico diversi
da quello Kantiano. Io suggerisco di comprendere tale progetto come una ricerca
dell’estensione e dei confini della normatività. La filosofia, comunque, non è
meramente critica. Essa ha anche una parte positiva, che è speculativa[9], nel senso che essa deve
investigare la natura della realtà come un tutto, e in questo senso essa deve
essere metafisica, pace Kant. Ma anche qui c’è metafisica e metafisica.
Certo, la metafisica è una disciplina a priori, che ha il compito di
descrivere le caratteristiche più generali della realtà e costruire il più
accurato sistema di categorie ontologiche, ma essa non può riuscire a fare ciò
in completo isolamento rispetto alla scienza. A questo riguardo essa non può
affermare di asserire la verità finale riguardo a ciò che c’è. Il razionalismo
non deve essere modesto nelle sue affermazioni sostantive e critiche riguardo
alla natura della conoscenza, ma deve essere modesto quando perviene
all’effettiva conoscenza del mondo[10].
5.
La ragione nel pubblico dominio
Il
mio manifesto razionalista deve sembrare deludente se si crede che la filosofia
debba prendere parte negli affari umani e politici e se ci si aspetta che essa
sia depositaria di un messaggio per l’umanità o almeno per la vita pubblica. Io
rifiuto l’assunzione che essa debba fare ciò. La filosofia è prima di tutto una
disciplina teoretica, che non deve necessariamente avere alcuna conseguenza
pratica. Questo implica, in primo luogo, che la filosofia può essere una impresa teoretica. Ciò non significa cha la
filosofia debba essere integrata come una disciplina empirica nelle scienze
naturali, cognitive o sociali. Razionalismo significa che non tutta la nostra
conoscenza è empirica. Una larga parte dei compiti critici e speculativi della
filosofia consiste nell’investigazione dell’ordine concettuale e normativo su
cui la nostra conoscenza empirica si basa e provvede una spiegazione delle più
fondamentali categorie della realtà. Nonostante ciò non possa esser realizzato
senza scienza, non è in sé stesso uno sforzo scientifico. In secondo luogo, la
filosofia dovrebbe essere una impresa teoretica, e non avere nulla a che
fare in particolare con il miglioramento delle nostre vite individuali o
collettive. In altre parole, io
condivido pienamente la diagnosi di Benda che il ruolo dei “chierici”, e dei
filosofi in particolare, è quello di coltivare i valori intellettuali e non
sacrificarli in nome di valori pratici e della politica. Ciò non significa che
i filosofi non devono avere a che fare con la sfera pratica e quella pubblica.
Al contrario, essi devono, in quanto è uno dei ruoli della filosofia quello di
comprendere la natura dell’azione e della vita etica. Ma il loro ruolo non è
quello di essere coinvolti nell’azione pubblica né di limitare sé stessi a proporre
varie concezioni della saggezza pratica. Un filosofo che non prendesse parte
alla vita pubblica non cesserebbe di essere un filosofo, ma un filosofo che non
prendesse parte alla vita teoretica cesserebbe di essere tale.
Sono consapevole che il tipo di concezione che ho qui presentato sarà
considerata come totalmente noiosa e reazionaria. Gli ordinari principi della
ragione – credi ciò di cui hai evidenza, segui la logica, non dire più di
quello che puoi sapere, eccetera – sembrano banali e noiosi. Se essi sono
costitutivi del nostro pensare e sono in ogni caso presenti, perché
preoccuparci a prescriverli? Ciò suona pedante o moralistico. Comunque, a
differenza dell’imperativo morale Kantiano, dove si può parlare di dovere fine
a se stesso, non si può parlare di ragione o logica fine a se stessa. Solo
paranoici o folli farebbero ciò. Si può solo parlare di ragione o logica per un certo scopo, che è la verità[11]. In filosofia il fine è
trovare verità metafisiche, concettuali e morali. Ma nessuno dice che si deve
rispettare la logica e la ragione ovunque e in ogni circostanza, in particolare
quando la verità non è di nostro interesse. Ma in filosofia la verità è il
nostro oggetto di interesse. Non è il nostro oggetto di interesse solo in
filosofia e nella scienza e nelle questioni intellettuali. Essa è anche il
nostro interesse in questioni etiche, politiche, e possibilmente estetiche, e
nella misura in cui ci sono verità in questi ambiti, il rispetto per la ragione
e la logica è importante anche lì. La ragione è noiosa? Certo che si, se si
adotta il credo di Nietzsche e Walt Whitman:
Mi contraddico?
Molto bene, allora io
contraddico me stesso.
(Io sono ampio. Contengo moltitudini)
Meglio essere ristretti, e contenere
solo se stessi, dice il razionalista classico. Ma la noiosa ragione può essere
anche divertente. La satira razionalistica, nelle mani di Swift, Voltaire,
Kraus, Benda, Russell e Orwell e molti altri che scrivono in nome della
Ragione, è difficilmente noiosa, sebbene sia vero che la ragione, essendo
ovunque la stessa, ha sempre lo svantaggio di sembrare monotona e ripetitiva se
confrontata con l’errore e il falso ragionamento che sono vari e molteplici.
Il razionalismo è reazionario? Certo, come suggerito in precedenza, il
tentativo di restaurare, quattro secoli più tardi, il razionalismo classico al
suo apice come si è sviluppato con Cartesio, Spinoza, Leibniz e Kant,
sembrerebbe essere una prospettiva reazionaria. Ma lo è solo se si pensa che la
filosofia deve sempre e ovunque, proporre qualcosa di radicalmente nuovo e
necessariamente adattare tutte le sue tesi ai cambiamenti d’epoca e di cultura.
Ma deve fare ciò? La ragione deve cambiare, adattarsi e essere “dinamica”?
Filosofi come Eraclito, Hegel, Marx, Bergson e altri hanno fondato la loro
intera carriera nel dominio delle idee sull’affermazione che il pensiero deve
essere “dinamico” e la ragione “flessibile” ai cambiamenti. Ma la ragione non
deve cambiare. Essa rimane sempre la stessa, almeno nei suoi principi
fondamentali. Ne segue che il programma razionalista è lo stesso per oggi e
domani come lo era per ieri. Il segno della reazione intellettuale non è il
tentativo, sempre rinnovato, di mantenere saldi i principi della ragione e di
comprendere come essi possono ancora valere nelle mutevoli circostanze. Il
segno della reazione è cadere vittima della tirannia del presente, e supporre
che le leggi della ragione cambieranno in futuro. Voltaire, Russell o Benda, che
non erano certo reazionari politici, avrebbero lasciato il loro segno sulla
storia della ragione e su efficaci interventi nella vita pubblica se avessero
creduto che la difesa dei suoi principi fosse meramente un episodio passeggero?
Quando la bella sveglia del suo profundo sonno, ella e sempre stessa.[12]
[1]
Si vedano le affermazioni di G.H. Hardy citate da C. P.Snow: “Have you
noticed how the word “intellectual” is used nowdays? There seems to be a new
definition which certainly does not include Rutherford, Eddington, Dirac nor
me. It does seem rather odd” ( The two cultures (1959), Cambridge 1998,p.3)
[3] Michael Friedman, A Parting of
the Ways, Carnap, Cassirer and Heidegger,
[4] Per un argumento per la differenza tra la verità e la iustificazione,
D. Marconi, Per la verita ,
Appendice, p. 161-164
[5] Per un buon argomento secondo
cui il pragmatismo, specialmente in Bergson, è essenzialmente
anti-razionalista, si veda Susan Stebbing, Pragmatism and French voluntarism
Cambridge University Press 1914,
[6] C. Peacocke ha articolato
questo tipo di programma razionalista in Concepts , MIT Press, 1992, Being
Known, Oxford 1999, e The realm of reason, Oxford 2004..
[7] Si
veda Timothy Scanlon, What we Owe to Each Others, Cambridge Mass,
Harvard University Press
[8]
See J . Skorupski’s impressive
work long these lines, The Domain of Reasons, Oxford University Press
2011, and D. Parfit’s On What Matters, Oxford University Press , 2011.
[9] “Critical and speculative
philosophy”, in Contemporary British
Philosophy: Personal Statements (First Series), ed. J. H. Muirhead (London: G. Allen and Unwin, 1924):
77-100
[10] Claudine Tiercelin, Le ciment des choses, petit traité de Métaphysique réaliste, Paris, Ithaque, 2011.
[11] I. Johansson, “Respect for Logic”,
Essays dedicated to Dag Westertahl for his 60th birthday, Dept. of
Philosophy, Göteborg University Web Series, No. 35, pp. 127-134 , 2003.
[12] Garzie a Davide Fassio per la sua traduzione di questo testo.
 |
| mort de La Palice à Pavie 1525 |